La magia del Foley artist: creare suoni realistici in post-produzione

Accade, quando guardiamo un film, uno spot, una serie in tv, che il nostro cervello faccia questo percorso: semplicemente dimentica di stare ascoltando suoni registrati. Ed è così che percepiamo come naturale, e realmente veritiero il suono di due scarpe che si muovono sulla ghiaia,o di un bicchiere che cadendo per terra si rompe in mille pezzi. Succede che “lo viviamo” come se stesse accadendo esattamente lì. Tutto appare naturale, davanti alla macchina da presa. Eppure, nella maggior parte dei casi, quei suoni sono stati ricreati dopo, in uno studio silenzioso, lontano dalle luci del set. A farlo è il Foley artist, un’altra tra le figure più “nascoste” del cinema, meno inflazionate volendo, ma assolutamente fondamentali e decisive.
E vediamo meglio perché non è un lavoro meccanico e non basta “premere play” su una libreria di effetti sonori. Il Foley artist lavora proprio su quel confine sottile tra realtà e percezione, quello che rende un film non solo visibile, ma anche “ascoltabile” con il corpo, oltre che con le orecchie.
L’arte di dare corpo ai suoni
Il lavoro del Foley artist inizia spesso e proprio nel silenzio, quello tecnico, controllato, in cui ogni suono è sotto osservazione e ogni rumore indesiderato è un intruso da eliminare.
Il suo operato inizia nel momento in cui si siede di fronte a uno schermo, pronto a “guardare con le orecchie” e a immaginare quello che il microfono sul set non è riuscito a catturare. Perché, anche se le riprese sono state perfette, la verità è che il suono diretto, quello registrato in presa diretta durante le scene, raramente è sufficiente a restituire l’esperienza sensoriale completa. C’è sempre un aereo che passa, un’auto lontana, un microfono che non coglie la profondità di un passo.
Si comincia da una visione attenta delle immagini, fotogramma dopo fotogramma, magari osservando tutti i dettagli e gli elementi presenti sulla scena e per cogliere possibili codici sonori. Non si cerca solo il suono di per sé, ma si vuole il suono giusto per quel preciso momento narrativo. Perché il compito non è replicare la realtà in modo sterile, ma crearne nuovamente una percezione, che è un aspetto molto più sottile. L’attrezzatura utilizzata non è fatta solo di microfoni e mixer, ma di oggetti reali di ogni tipo, perché questo rappresenta un archivio vivo di possibilità sonore. Il Foley artist non è un semplice tecnico, è anche un performer, perché si alza, si sposta, lavora in piedi, entra fisicamente nei gesti degli attori per sincronizzare i movimenti. Così una corsa sulla neve, magari sarà una corsa in studio ma su di un misto di farina di mais e amido di mais.
Ogni passaggio è provato più volte, cercando la perfetta corrispondenza temporale con le immagini. C’è anche un aspetto quasi psicologico poiché il Foley artist deve entrare nel ritmo emotivo della scena. Questi dettagli non sono casuali, ma frutto di uno studio continuo del linguaggio non verbale, tradotto in linguaggio sonoro. Spesso, poi, c’è un lavoro di sperimentazione. Alcuni suoni semplicemente non esistono in natura nella forma in cui servono.
E non c’è margine per l’approssimazione, per l’errore. Ogni suono deve essere vero o almeno credibile e sincronizzato al millisecondo, perché l’occhio umano è impietoso quando nota che un passo “cade” fuori tempo o che un oggetto emette un rumore un istante prima di essere toccato.
Alla fine, il risultato è una traccia sonora che sembra essere nata sul set, eppure è frutto di ore di registrazioni, prove, tagli e mixaggi.
È come se il Foley avesse il potere di aggiungere un quinto senso alla visione.
Dalla radio ai grandi set ecco un mestiere che si è reinventato più volte
La figura del Foley artist è nata quando il cinema stava imparando a parlare. Fino alla fine degli anni Venti, le sale proiettavano film muti, accompagnati da un pianista o da un’orchestra che interpretava dal vivo le emozioni sullo schermo. Poi è arrivato il sonoro e, ma non bastava più aggiungere musica, serviva dare corpo all’ambiente, restituire l’illusione che ciò che si vedeva fosse reale anche all’orecchio.
Il nome stesso, “Foley”, viene da Jack Foley, un tecnico e artista del suono della Universal Studios che, tra gli anni Venti e Trenta, inventò un metodo per registrare effetti sonori dal vivo, in sincrono con le immagini. Non si trattava solo di colpi o rumori di fondo, ma di un vero e proprio accompagnamento fisico alla scena. Foley e il suo team guardavano il film proiettato e, in contemporanea, producevano i suoni necessari: passi, porte che si aprivano, vestiti che frusciavano, oggetti che cadevano. Il tutto registrato in diretta, come se fosse una performance teatrale… ma per il microfono.
Negli anni, la tecnica si è raffinata. Nei decenni del dopoguerra, quando Hollywood era nel pieno della sua età d’oro, i grandi studi avevano intere sale Foley, con pavimenti intercambiabili (legno, piastrelle, ghiaia) e pareti rivestite di materiali diversi per variare la risposta acustica.
L’abilità stava non solo nel riprodurre il suono giusto, ma anche nel capire quale microfono usare, da quale distanza registrare e con quale intensità interpretare il gesto. Era un mestiere artigianale, quasi coreografico, dove il tempismo contava quanto la qualità del suono.
L’avvento delle tecnologie digitali, a partire dagli anni Novanta, ha cambiato radicalmente il panorama. Oggi esistono immense librerie di effetti sonori pronti all’uso, e per molte produzioni a basso budget la tentazione di pescare un rumore da un archivio è forte. Ma un suono preso in archivio è, per sua natura, generico. Non tiene conto della realtà, né del tono, ed ecco perché, anche in un’epoca di software avanzati e intelligenza artificiale, il Foley artist resta comunque, e per il suo lavoro, una risorsa insostituibile. Oggi il mestiere è diventato un ponte tra due mondi: quello analogico, fatto di oggetti reali, microfoni direzionali e registrazioni “fisiche”, e quello digitale, dove i suoni registrati vengono elaborati, ripuliti, mixati in modo da integrarsi perfettamente nel film e molti Foley artist lavorano in team ristretti, spesso in coppia con un “mixer” che, in sala, bilancia i volumi in tempo reale, corregge eventuali sbavature, aggiusta i livelli per garantire coerenza tra le varie tracce.
C’è anche un’evoluzione nel linguaggio sonoro stesso. Il pubblico di oggi, abituato a contenuti ad altissima definizione e a esperienze immersive, è molto più esigente. Noterebbe subito se un suono non “combacia” con ciò che vede, anche senza rendersene conto in modo razionale. Questo obbliga i Foley artist a una precisione ancora maggiore, e spesso a studiare il contesto culturale della storia che stanno sonorizzando. In Italia, poi, il mestiere ha una sua tradizione importante con i grandi studi di doppiaggio e post-produzione di Roma e Milano che hanno ospitato generazioni di Foley artist che hanno lavorato non solo per il cinema, ma anche per pubblicità, documentari e fiction televisive. È un lavoro che raramente compare nei titoli di testa, ma c’è la soddisfazione di sapere che, se il pubblico si è immerso in una storia senza mai staccarsene, è anche merito di quei suoni creati con cura maniacale, passo dopo passo, fruscio dopo fruscio.
il suono invisibile che fa vivere le immagini
Il lavoro del Foley artist è, in fondo, un atto di fiducia. Fiducia nel fatto che un passo, un respiro, un colpo di porta possano trasformare un insieme di immagini in una storia viva. Fiducia nel sapere che oggetti comuni diventano strumenti narrativi, per dare corpo sonoro alle emozioni visive.
Così il Foley rimane la prova che il tocco umano ha ancora un valore insostituibile nel dare valore reale a quel mondo che, senza di lui, sarebbe muto e non si potrebbe far giungere a chi ha l’orecchio, e il cuore, per ascoltare.
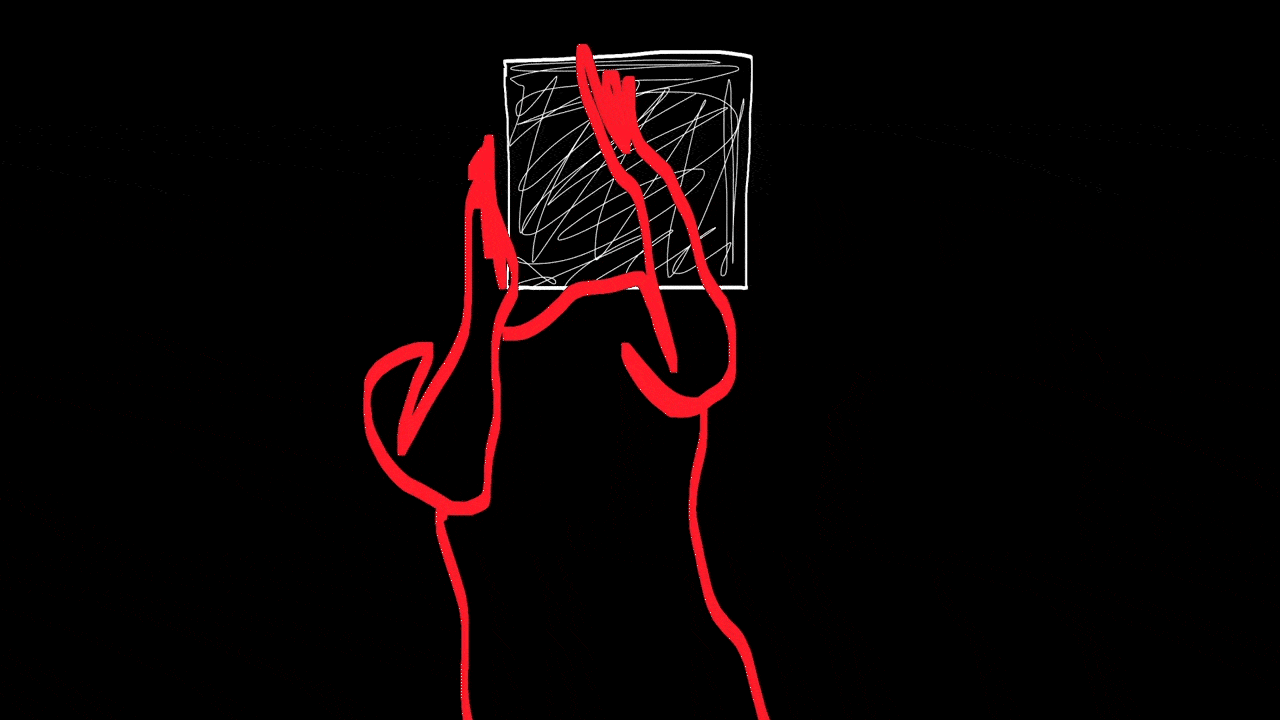
Ascolta anche
Leggi anche
Media planning tv…
Il proof of conce…
Dal table top all…









